Non ci sono libri nel tuo carrello.
| 0 Libri | €0,00 |

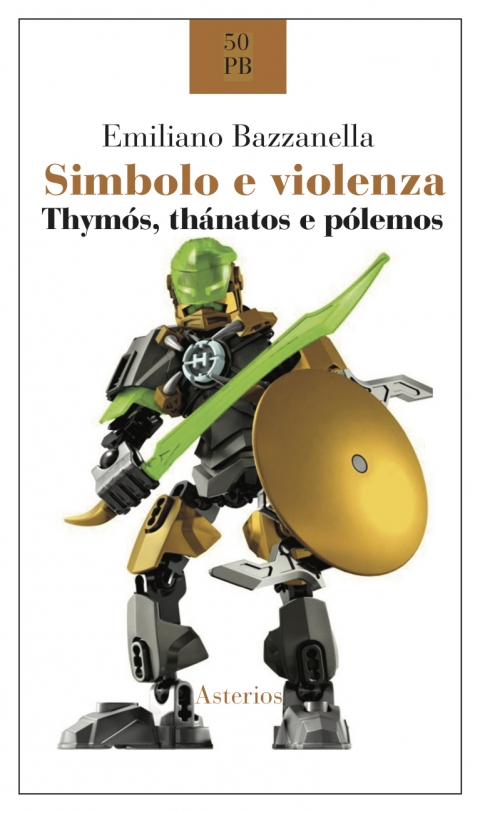
La storia del pensiero ci consegna varie teorie sulla violenza che l’autore
di questo saggio cerca di attraversare: la celebrazione sacralizzante dell’epica
antica che culmina nella figura ambivalente dell’“eroe”; l’esclusione
sistematica da parte di un’impostazione illuministica (persistente ancora
oggi) che vi intravvede il residuo evidente dell’animalità e di un’arcaicità
tribale presenti ancora in certi riti primitivi ed esotici; la “trascendentalizzazione”
per cui il thymós, la rabbia e il furore costituiscono una realtà
ineludibile del mondo umano, realtà che deve essere continuamente immunizzata
con tecniche magiche, religiose e psico-politiche; la “naturalizzazione”
delle forme di assoggettamento ed umiliazione sociale come la
riscontriamo con una certa sorpresa proprio in Aristotele, per il quale, ad
esempio, la “schiavitù” assume il rilievo ontologico di una realtà inemendabile
e persino biologica e fisiologica; le integrazioni “filo-polemologiche”
che a partire da Eraclito per finire con Heidegger e Sloterdijk tendono a
far corrispondere il conflitto e la guerra con il lógos come se si trattasse di
un agone sublimato e ritualizzato; le critiche (Lévinas) provenienti dal filone
ebraico che associano la violenza ad una determinata evoluzione del
pensiero occidentale e metafisico, per lo più riconducibile al mondo cristiano
e latino; le tesi “edificanti” che celebrano la violenza quale agente
politico-sociale emancipatorio e rivoluzionario (Arendt, Benjamin, Žižek,
etc.); le tesi “economicistiche” per cui la violenza innerverebbe il tessuto
stesso dell’economia e dello scambio delle merci, come se la guerra costituisse
il naturale prosieguo del commercium tra le persone (e come si
evince dal medesimo lessico economicistico odierno in cui prevalgono termini
che fanno pensare ad una vera e propria battaglia senza esclusione
di colpi tra i competitors); le infatuazioni e fascinazioni intellettuali per
cui la guerra non soltanto appare ineludibile ed inevitabile, ma assurge al
ruolo di “concetto assoluto” e “quasi” puro, subendo una sorta di idealizzazione
platonica estrema e quasi beffarda (Schmitt, Clausewitz); le “rimozioni”
per cui ciò che chiamiamo genericamente civiltà e cultura non
sarebbero che forme di trasformazione rituale e simbolica di una violenza
originaria ed illegittima (Girard e per certi aspetti Derrida), a partire dall’istituzione
di una norma e del diritto conseguente. Per offrire un’immagine
sufficientemente tragica di questo scenario contrapposto, Auschwitz
può rappresentare nel medesimo tempo il punto più basso della degenerazione
dell’uomo e della sua natura bestiale (posto che esista o possa esistere
una violenza prettamente “animale”); oppure l’apice di un processo
di razionalizzazione così estrema da fornire un contenuto di senso a ciò
che non ne ha, né può averne; oppure – ancora – può divenire la semplice
e puntuale applicazione di un certo formalismo, una sorta di concetto assoluto
in cui il lógos diviene quasi consequenzialmente “tanatologico”.